Dalla banalità del male al male della banalità

Di Davide Strukelj.
Introduzione
“Dalla banalità del male al male della banalità”, tecnicamente, sarebbe un chiasma, un incrocio, un’inversione operata su una coppia di parole che ha la funzione di sospendere il pensiero razionale e aprire i canali della percezione subliminale. È un metodo, un trucco, se volete, usato nella comunicazione umana. Lo dichiaro in apertura perché proprio di questo vorrei parlare. Della comunicazione umana.
Lo faccio così, spudoratamente, perché in questa simmetria inquietante, quella della banalità e del male, credo si celi la parabola della nostra epoca.
Se il Novecento ci ha insegnato che il male può travestirsi da normalità – incarnarsi in funzionari grigi, obbedienti e mediocri, nascondersi nelle parole che rimuovono la morale e la sostituiscono col burocratico processo deciso dall’alto – il XXI secolo ci sta mostrando qualcosa di ancora più sottile e pervasivo: la banalità non è più soltanto il veicolo del male, il vestito accettabile col quale coprire un corpoimputridito. La banalità è diventata essenza, forma e contenuto del discorso pubblico.
Parliamo, comunichiamo, discutiamo come mai nel nostro passato di Homo sapiens, ma lo facciamo con un linguaggio ridotto, urlato, privo di sfumature, senza le articolazioni necessarie a spiegare e a comprendere. Le idee sono scadute nei meme, il dibattito nella polemica, la complessità nel sospetto. Ogni cosa deve essere semplice e immediata, come una piccola caramella: si scioglie in un istante e poi svanisce nel nulla.Se ciò non accade, scatta immediato il rigetto, il sospetto, l’accusa di voler complicare solo per confondere.
I social network, universalmente indicati come la causa di ogni male, non hanno soltanto modificato il modo in cui comunichiamo. Hanno imposto un nuovo canone culturale, basato sulla reazione istantanea, sull’emotività, sull’indignazione a basso costo. E ciò che ne emerge non è soltanto una cultura superficiale, ma un sistema che premia la banalità e punisce la complessità.
In questo nostro secolo, che avrebbe dovuto essere l’era della conoscenza diffusa, ci ritroviamo sommersi da messaggi semplificati al punto da diventare privi di significato. E così, proprio mentre il mondo si fa sempre più complesso, le nostre chiavi di lettura si fanno sempre più elementari; il nostro linguaggio sempre più povero e con esso anche il nostro pensiero si appiattisce, ridotto a una pochezza di parole: sempre meno numerose, sempre più generiche, sempre meno capaci di dar forma a idee articolate.Il linguaggio non è solo uno strumento del pensiero, è la sua materia prima: se il vocabolario si impoverisce, il pensiero diventa modesto e impreciso.
Ecco allora che nel breve volgere di un secolo siamo passati dalla “banalità del male” – quella che Arendt scoprì osservando Eichmann – al male profondo e strutturale della banalità che pervade il nostro tempo.
Insomma, se cento anni fa il male si vestiva di banalità per nascondersi dietro a parole e comportamenti socialmente accettabili (“facevamo il nostro dovere”, “eseguivamo ordini”), oggi la banalità ha preso il sopravvento nella nostra comunicazione diventando essa stessa agente e non più scusante.
Già al tempo Gitta Sereny osservava che Franz Stangl “non era un sadico,non era crudele, era un uomo che trovava più facile non pensare” (In quelle tenebre, 1974). Oggi quella banalità di copertura, quel nido ovattato della coscienza personale, è divenuta interprete assoluta della nostra società. Da comparsa a protagonista. La banalità ha vinto.
Dalla manipolazione delle masse alla semplificazione algoritmica
Anche solo osservando il nostro mondo, appare evidente come la banalità contemporanea non sia una degenerazione spontanea. Si tratta piuttosto dell’esito di un processo lungo, per certi versi lucido e consapevole.
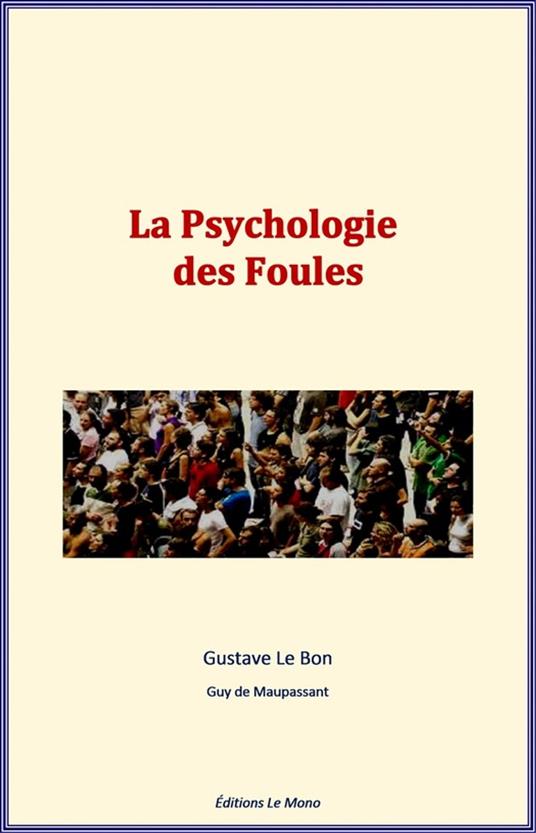
Fin dall’inizio del Novecento, alcuni pensatori avevano intuito che la nascente società di massa non poteva essere governata con gli strumenti del dibattito razionale o del confronto democratico inteso come discussione collettiva e aperta, ma non solo per una scontata questione di numerosità degli interlocutori, quanto per il fatto che la massa di esseri umani (come la massa di altre specie viventi) si comporta secondo dinamiche differenti e peculiari.
Gustave Le Bon, ne La psicologia delle folle (1895), aveva descritto con tono quasi clinico l’irrazionalità della massa: le folle non ragionano, reagiscono; non valutano argomenti, ma si affidano a immagini, emozioni, gesti teatrali. Per un osservatore inesperto sembra paradossale, lo capisco, ma chiunque abbia mai ragionato sulla questione sa benissimo che la massa, ovvero la folla, come la chiamava Le Bon, si comporta come un organismo a sé stante. La folla è come un individuo nuovo, non il risultato della somma dei singoli che la compongono, ma un’entità del tuttooriginale, con caratteristiche proprie, comportamentispecifici, credi, riti e opinioni.
Walter Lippmann, già negli anni ‘20, sosteneva che l’opinione pubblica (termine che lui stesso aveva coniato proprio per differenziarla dall’opinione del singolo) non poteva formarsi liberamente in un mondo complesso e interconnesso. Nel suo saggio Public Opinion (1922), proponeva un’idea di democrazia “gestita”: il cittadino medio, quale componente della massa, avrebbe avuto bisogno di immagini semplificate, create da esperti, tecnici e comunicatori. Per questo, secondo lui, si rendeva necessario costruire una narrazione guidatae appositamente confezionata.
A raccogliere questa intuizione e a metterla in pratica fu Edward Bernays, considerato il padre della propaganda moderna. Nel suo libro Propaganda (1928), Bernays scrive: “La manipolazione cosciente e intelligente delle abitudini e delle opinioni delle masse è un elemento importante della società democratica.”
Da allora in poi è stato un fiorire di tecniche, esperti e manualistica di cui i nostri tempi non sono che la diretta conseguenza.
Emerge così che la riduzione della complessità a simboli e slogan non è un effetto collaterale, come potrebbesembrare, ma un vero e proprio progetto funzionale. E i social media, che oggi usiamo con indifferenza, non hanno fatto altro che automatizzare e accelerare questo schema, digitalizzando la propaganda, rendendola onnipresente, continua, interattiva e sempre più gestita da algoritmi dei quali la quasi totalità degli esseri umani ignora ilfunzionamento.
La propaganda politica come apologia della banalità
Le campagne elettorali, i talk show, i tweet presidenziali, i meme virali: tutto oggi sembra urlare velocità, emozione, semplificazione. La retorica politica non è più costruita sull’argomentazione, ma sull’impatto. Il discorso razionale è stato sostituito da slogan polarizzanti, confezionati per generare reazioni viscerali e immediatamente condivisibili.
Esempi recenti? Il “Make America Great Again” di Trump. Il “Take Back Control” della Brexit. Il “Prima gli italiani” del sovranismo nostrano. Frasi brevi, evocative, prive di contenuto analitico ma cariche di simboli. La contrazione del linguaggio è proceduta secomdo una iperbole inarrestabile, fino a diventare parola singola: patrioti, identità, radici, cristianità, noi… Tutte parole (significanti) svuotate dal significato complesso e contestuale che devono avere, per diventare strumento adatto a incidere nelle emozioni profonde, evocando in ciascun destinatario un dettato valoriale specifico, autoprodotto e dunque efficace di per sé.Una parola sola per dire tutto. O per non dire nulla.
E così il linguaggio della politica si è adattato perfettamente all’ecosistema digitale. In un ambiente dove la soglia di attenzione media è inferiore agli otto secondi, la complessità è diventata un ostacolo. Il pensiero lungo è incompatibile con il formato.
Ma il problema non è solo stilistico. Quando il linguaggio si banalizza, anche la realtà si deforma. I problemi diventano nemici, le domande si riducono a colpe, la diversità è vista come minaccia. Il pensiero critico viene sostituito dal riflesso emotivo: mi piace/non mi piace, vero/falso, noi/loro.
Il risultato? Una società che reagisce a tutto, con immediatezza, ma non comprende nulla.
Capire la complessità: una sfida cognitiva e culturale
Molto spesso, in questi ultimi anni, abbiamo sentito parlare di complessità. “Il mondo è complesso”, “questo è un problema complesso”; affermazioni simili sono diventate frasi ricorrenti anche nella chiacchiera comune.
Ma che cos’è davvero la complessità?
La complessità, in senso scientifico, è la condizione di sistemi formati da molti elementi,tra loro variamente interconnessi, le cui interazioni generano comportamenti emergenti non riconducibili alla semplice somma delle parti. È un po’ come il nostro cervello: un singolo neurone non è in grado di fare quasi nulla, ma un numero molto elevato di neuroni, tra loro collegati da miliardi di connessioni, può produrre processi incredibilmente elaborati, così tanto specifici e nuovi da non essere riconducibili alle funzioni del neurone stesso. Insomma, se guardiamo un neurone isolato, niente ci potrebbe far pensare che il cervello sia in grado di fare ciò che fa.
Va da sé che per comprendere un sistema complesso sono necessarie abilità specifiche e strumenti appropriati, tra i quali, da esempio, i modelli di processo e adattamento,il pensiero laterale, la visione sistemica, l’interdisciplinarietà, l’umiltà epistemica, solo per citarne alcuni. Insomma, l’approccio alla complessità deve essere adattivo, iterativo e flessibile e richiede un monitoraggio continuo, la verifica continua delle ipotesi e una serie di strategie dinamiche.
Altro aspetto fondamentale è che la cultura della complessità impone di tollerare l’incertezza, accettare il dubbio, ascoltare punti di vista divergenti.
La complessità, insomma, richiede pazienza, formazione, lentezza: tutte qualità che la banalità mediatica contemporanea tende a respingere.
Da Eraclito a Prigogine: pensare in movimento, concentrati sulle discontinuità
“Il sole è nuovo ogni giorno”, scriveva Eraclito. Un’interpretazione banale di questa breve frase ci farebbe concentrare sul fatto che tutto è in divenire (tipico concetto collegato al pensiero del filosofo), oppure sul fatto che tutto ricomincia sempre da capo (altra semplificazione ricorrente). In realtà, nella mia interpretazione, Eraclito ci vuole dire che anche ciò che diamo per scontato, come il sorgere del sole, porta con sé, ogni volta, un carico di novità: il sole è “nuovo” ogni giorno.Questo è complessità, questo è comprendere che quando vogliamo ragionare non possiamo mai accontentarci di ciò che abbiamo compreso, perché ogni volta la realtà ci si presenterà con una verità differente, che noi dobbiamopenetrare e gestire.
Una immagine potente, nella sua essenzialità, con cui Eraclito indica che la verità che ci appare non è mai ferma, mai identica a sé stessa, mai fissabile una volta per tutte.
Non esiste una fotografia definitiva del reale: esiste un flusso continuo, un intreccio dinamico di trasformazioni. Capire il mondo non significa arrestarlo in uno scatto statico, ma accompagnarlo nel suo divenire, cogliendone relazioni, discontinuità, metamorfosi.
La conoscenza autentica, quindi, non cerca mai di semplificare la complessità, ma di stare dentro di essa, come un navigante che corregge la rotta osservando il mare, le correnti, i venti.
In questo senso, la visione di Eraclito anticipa quella di pensatori moderni come Ilya Prigogine, per il quale “La complessità non è un incidente, ma la forma stessa della vita.”
Entrambi ci ricordano che il mondo non è una macchina da decifrare, ma un organismo in continua evoluzione, che non chiede controllo, ma ascolto e adattamento.
E così, in un mondo che si trasforma a ogni istante, non può essere la semplificazione a salvarci, ma la nostra capacità di abitare la complessità. Ed è proprio questa capacità che la banalità, oggi, ci sta sottraendo.
Il paradosso della complessità: un mondo difficile raccontato con parole semplici
Viviamo nell’epoca più interconnessa e fragile della storia dell’umanità. Ogni evento – una crisi energetica, una pandemia, una guerra – produce onde d’urto globali. Il mondo ci chiede, oggi più che mai, di diventare interpreti lucidi, capaci di pensiero sistemico, di profondità.
Proprio per questo la ragione vorrebbe ricondurci alla complessità, ricordandoci che essa si muove tra la quiete della stabilità e le rivoluzioni indotte dai suoi punti di discontinuità. Questi punti sono luoghi del tutto speciali, nei quali un piccolo mutamento è capace di indurre nuovi e spettacolari stravolgimenti del sistema, spingendolo verso assetti di equilibrio del tutto inaspettati.
Eppure, proprio ora che la vita ci sfida con la sua complessità, le nostre risposte culturali si sono fatte semplici fino alla distorsione. Il lessico pubblico si è ridotto a parole-segnale: emergenza, nemico, libertà, sicurezza, identità.Il linguaggio semplificato ci protegge nel pensiero, ma ci espone alla manipolazione. Invece di confrontarci con la complessità, la rimuoviamo. Tutto ci spinge a reagire d’istinto, sulla base di emozioni indotte, mai a riflettere.
Che fare?
Partiamo dal presupposto che la banalità ha trionfato perché è economica, rapida, seducente.
Ma esiste un’alternativa? Ebbene sì, esistono percorsi possibili: talvolta impervi, ma certamente accessibili.
Per prima cosa dobbiamo riabilitare la complessità. Dobbiamo riportarla al centro del dibattito nella sua accezione scientifica, senza svilirla a mera iperbole lessicale. Questo è un preciso dovere etico e civico.
Di conseguenza è necessario educare al dubbio. Chi fornisce certezze “prêt-à-porter”, il più delle volte espresse con frasi elementari tipo “soggetto-predicato verbale-complemento oggetto”, va discusso e messo alla prova. Il pensiero critico deve avere il sopravvento.
Bisogna riportare il linguaggio al centro della formazione; è fondamentale restituire ai parlanti la ricchezza delle parole, la complessità dei significati, l’importanza della contestualizzazione, la precisione nell’utilizzo dei vocaboli. Un linguaggio misero produce pensieri miseri.

Dobbiamo valorizzare la lentezza. Comprendere non è mai immediato; ragionare è faticoso e richiede concentrazione ma anche riposo, defaticamento, distrazione. Il nostro cervello pensa anche quando non sentiamo fluire la nostra vocina interiore; lasciamolo lavorare consapevoli dell’ importanza di quei momenti di silenzio; poi ritorniamo sugli argomenti per razionalizzare le idee, ordinare i pensieri e confrontarci con gli altri.
Difendiamo in tutti i modi i luoghi del pensiero: scuole, università, giornalismo indipendente, associazioni, luoghi d’incontro informali. Le persone che pensano costruiscono idee. Le persone che dialogano usano le idee per costruire il mondo.
In conclusione, non possiamo certo chiedere alla complessità di diventare popolare. Ma possiamo chiedere alla cultura di non arrendersi alla tirannia della semplificazione.
In un tempo in cui la banalità regna indisturbata, ragionare con rigore, parlare con precisione, ascoltare e pensare con lentezza sono atti rivoluzionari.
Forse il futuro della nostra cultura dipenderà proprio da questo:da quanti avranno ancora il coraggio di scegliere la complessità in un mondo che pretende schemi stimolo-risposta immediati e istintivi.
“Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove trovarle” dicevaUmberto Eco. Vorrei aggiungere che dovremmo anche sapere come ragionare su di esse e non avere paura della complessità che le circonda.
Ampliare la platea dei pensanti deve essere una missione per chiunque creda ancora che non tutto è perduto, e che il sole, ogni giorno, porta con sé nuove opportunità.
